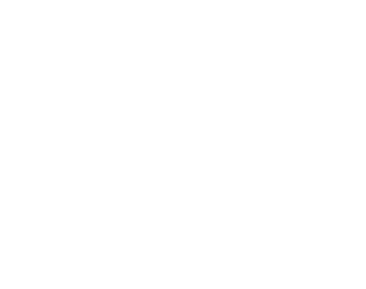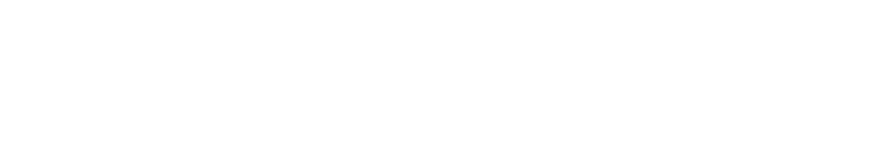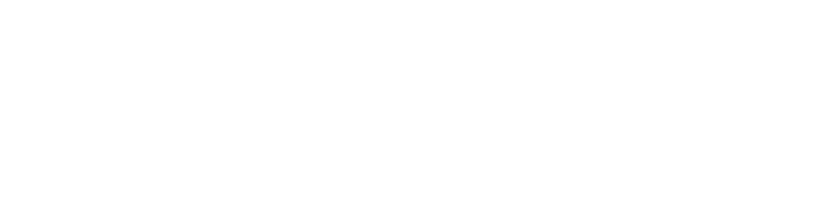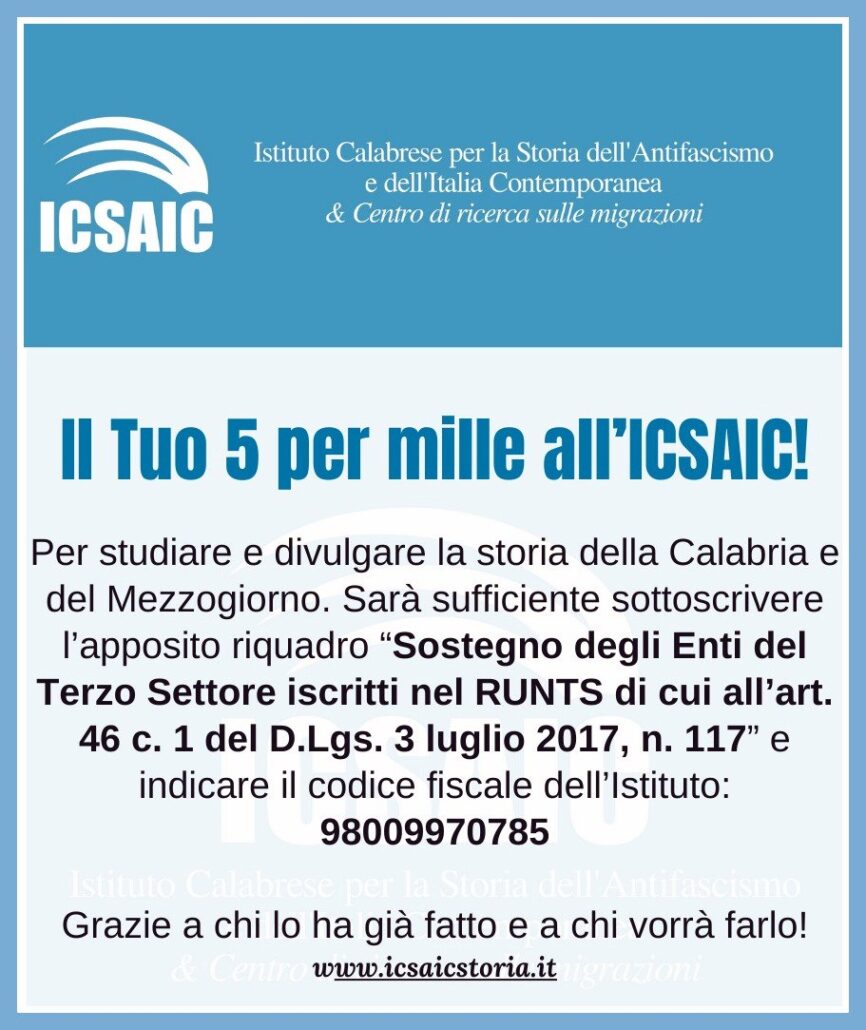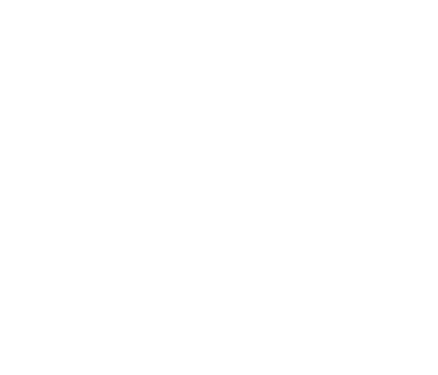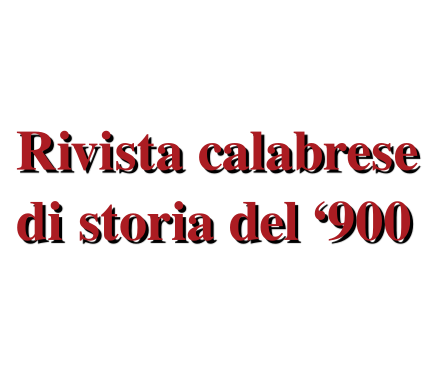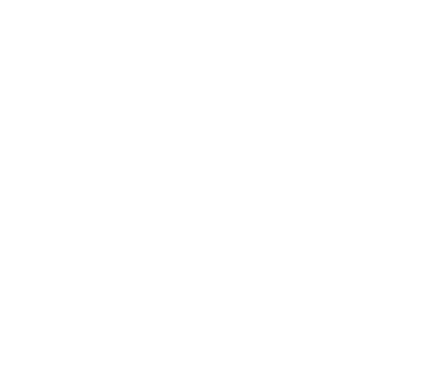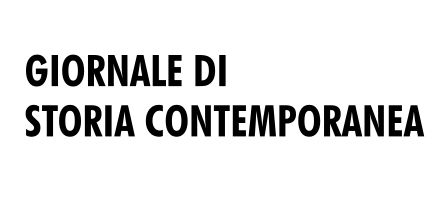Pubblichiamo l’intervista allo storico Giuseppe Ferraro, coordinatore della commissione didattica dell’ICSAIC, pubblicata su Il Quotidiano del Sud il 24 aprile 2025.
di Davide Scaglione | Il Quotidiano del Sud
COSENZA – Ottant’anni sono passati dalla fine della Seconda guerra mondiale e dalla Liberazione. Una ricorrenza solenne per l’Italia e l’intera umanità. Eventi totalizzanti che hanno generato effetti dirompenti nel breve e nel lungo periodo. In questa intervista, il professor Giuseppe Ferraro ci parla di questa importante pagina di storia con particolare riferimento al contributo e al sacrificio della Calabria e del Mezzogiorno nella guerra di Liberazione culminata nel 25 aprile. Ferraro è dottore di ricerca presso l’Università di San Marino. Dirige l’Istituto per la storia del Risorgimento di Cosenza, è dirigente dell’Istituto Calabrese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea e deputato di storia patria per la Calabria e collabora con l’Università del Salento.
Professore il Novecento, il secolo breve, ha esordito con la Prima guerra mondiale, un evento devastante per l’umanità. Ma la Seconda guerra mondiale ha avuto un impatto ancor più micidiale su milioni di persone. Ricorre l’ottantesimo anniversario della fine del conflitto.
«Il secondo conflitto mondiale riuscì a raggiungere livelli di violenza e distruzione che la Grande guerra aveva solo in parte anticipato. Tra il 1939 e il 1945 il mondo avrebbe combattuto una guerra che prevedeva l’annientamento totale del nemico in maniera ancora più estrema rispetto alla prima. Fu un conflitto totale e totalizzante. E ci furono anche guerriglie, rappresaglie, bombardamenti, occupazioni e invasioni, con una forza di penetrazione senza precedenti nella vita di milioni di persone. La guerra dal 1939 non è più solo trincea, ma subisce una dilatazione prima impensabile. È infatti il primo conflitto con più vittime civili che militari. A questo si aggiunge la componente di odio razziale verso popolazioni ritenute “non ariane” e quindi oggetto di violenze inaudite, pensiamo ai 6 milioni di ebrei morti nei campi di sterminio, ma anche alle migliaia di civili che divennero vittime del nazifascismo nei vari scenari di invasione e di occupazione».
Dopo la Grande Guerra sembrava che gli Stati avessero imparato la lezione. Ma a poco più di vent’anni dal termine delle ostilità il mondo è ripiombato in un conflitto che si è rivelato ancora più tremendo. Quanto ha pesato l’eredità della prima guerra mondiale?
«Mi verrebbe da rispondere che la storia è maestra di vita, ma forse le sue aule hanno poco scolari, soprattutto tra politici e militari. In realtà nel 1918 si mise fine ad un conflitto, ma si crearono politicamente, economicamente, diplomaticamente, ma aggiungerei anche psicologicamente, le premesse del secondo conflitto mondiale. Già l’aver dato la responsabilità morale e materiale della Prima guerra mondiale solo alla Germania produsse un senso di malessere sociale e psicologico che alimentò il desiderio di rivincita. Hitler alimentò la propria azione e propaganda facendo leva sull’umiliazione subita dalla Germania e, a detta dei nazisti, accettata passivamente, dalla Repubblica di Weimar, la più importante e originale esperienza democratica nel cuore di Europa. La Grande guerra fu un laboratorio di violenza militare e politica. Finito questo conflitto milioni di persone rimasero ancorati in questa dimensione che caratterizzò i primi anni del dopoguerra con violenze e scontri. A questo si potrebbe aggiungere la paura di alcuni settori della società verso la rivoluzione sovietica, che portò non poche classi dirigenti a vedere in questi movimenti e partiti, fascisti e nazisti, un’ancora di salvezza. Gli Stati liberali, potremmo dire a più di cento anni da quelle decisioni, furono miopi, esacerbarono i nazionalismi e continuarono a dividersi il mondo come avevano fatto prima del 1914 (dato che non era sfuggito a Wilson), basti pensare alla presenza di Francia e Inghilterra in Medio Oriente».
La Calabria, un piccolo lembo nell’Europa dilaniata dalle guerra, sembrerebbe aver avuto un ruolo marginale in un evento così globale. È davvero così?
«Quando si pensa ai due conflitti mondiali un po’ l’impressione più diffusa è questa. Ma in realtà è difficile rimanere marginali nei conflitti del XX secolo con la loro forza di penetrazione. Anche per un territorio isolato come la Calabria, dove il fascismo mandava i suoi oppositori al confino. In riferimento al secondo conflitto mondiale la Calabria è un tassello del più grande mosaico. Ricordiamolo, la guerra 1939-1945, è anche nel Mediterraneo. L’Italia di Mussolini vuole combattere la sua guerra parallela rispetto alla Germania anche nel Mediterraneo (guerra alla Grecia, Iugoslavia e Africa Mediterranea). Anche i nazisti prestano una forte attenzione al sud Europa per il suo ruolo strategico e per contrastare gli inglesi in Egitto e Medio Oriente. Sconfitta la Francia Mussolini e Hitler guardano all’Africa mediterranea per schiacciare e combattere l’Inghilterra. Nel settembre del 1943 proprio il sud, quindi anche la Calabria, diventano teatro centrale delle operazioni di sbarco anglo-americano. Il primo passo militare della liberazione inizia al Sud».
25 aprile 2025, ottant’anni dalla Liberazione, dicevamo, che ruolo ha avuto il Mezzogiorno e in particolare la Calabria nella lotta partigiana nell’Italia centro-settentrionale?
«In Italia è attiva una rete di Istituti per la storia della Resistenza che fanno riferimento all’Istituto nazionale “Ferruccio Parri” di Milano. Anche noi abbiamo il nostro, si tratta dell’Istituto calabrese per la storia dell’antifascismo e dell’Italia contemporanea. Proprio nell’ambito delle ricerche in seno a questi Istituti sono emersi dati molto importanti sulla partecipazione dei meridionali alla lotta di resistenza al nazifascismo, quindi anche in relazione alla Calabria. Dopo l’armistizio molti soldati calabresi sbandati dai Balcani e di ritorno in Italia decisero di continuare a combattere non più per il fascismo, ma per la libertà, decisero di salire sulle montagne dei territori italiani centrosettentrionali per aggregarsi o dare vita a bande partigiane. Si tratta di uomini e donne. Storie spesso poco conosciute, ma che fanno parte a pieno titolo del grande libro della storia della Resistenza italiana. Si tratta anche di civili presenti al nord per questioni socio-economiche, emigrazione interna dal sud, che aderiscono alle bande partigiane, svolgono ruoli di sostegno, informativi, di staffetta e di copertura. I nomi potrebbero essere tanti. Personalmente ho studiato e curato le biografie dei fratelli Nicoletta di Crotone: Giulio fu comandante della Divisione autonoma “Sergio De Vitis”. I fratelli Tallarico di Marcedusa in provincia di Catanzaro: Federico, più conosciuto come il comandate “Frico”. Sempre in Piemonte si trovò a svolgere il ruolo di staffetta partigiana Anna Cinanni, la sorella del funzionario comunista Paolo. Nome di battaglia “Cecilia”. Successivamente venne arrestata e sottoposta a disumane torture per fare i nomi della sua banda partigiana, ma non si fece vincere dalla violenza, evitò la morte solo grazie alla liberazione della città di Torino giusto in tempo. Tutti furono in primo piano nella liberazione di Torino, come altri partigiane e partigiani calabresi in altri territori occupati dai tedeschi. Forse proprio nella Resistenza troviamo una partecipazione trasversale socialmente e geograficamente irripetibile per la storia italiana».
Esistono pagine di storia che raccontano anche una Resistenza senza armi. Il riferimento è ovviamente alle azioni e alle varie forme di ribellione nei campi di concentramento.
«Anche di queste storie, poco note, si è nutrita il desiderio di libertà e poi la democrazia italiana. Spesso hanno subito non pochi filtri o censure, dovute ad opportunismo geopolitico dettato dal clima di guerra fredda, ma anche dalla volontà dei protagonisti in molte occasioni di dimenticare. Dopo il 1945 non tutto cambia davvero, pensiamo alle continuità nella magistratura e negli apparati dello Stato. Molti partigiani finirono a processo dopo la liberazione. Penso che sia giusto ricordare anche la storia degli internati militari italiani: gli Imi. Soldati italiani che dopo l’8 settembre vissero sulla propria pelle le contraddizioni dell’alleanza con i tedeschi. 600 mila di questi soldati, impegnati soprattutto nei Balcani, una volta disarmati e arresisi ai tedeschi furono destinati nei campi di internamento nei territori del Reich (alcuni non cedettero le armi come nel caso di Cefalonia e Corfù). 100mila non fecero più ritorno a casa. In quei campi di internamento non era la stessa cosa che andare a finire in quelli di sterminio, ma il trattamento loro riservato fu durissimo: disprezzati dall’ex alleato non poterono nemmeno appellarsi alla condizione di prigionia, perché volutamente la Germania non li considerò tali. Morirono di fame, freddo, di malattie, in un contesto di continue umiliazioni e sfruttamento. Ma molti, nonostante tutto, preferirono rimanere nei campi di internamento piuttosto che rispondere sì alle richieste della Repubblica sociale italiana che li voleva nelle fila del proprio esercito in Italia. È stata definita una resistenza senz’armi. Tra questi tanti meridionali e calabresi. Che vissero un’esperienza ancora più traumatica, l’assestamento del fronte per mesi impedì loro di ricevere lettere e pacchi alimentari dalle proprie famiglie».
Cosa ha rappresentato e rappresenta la Seconda guerra mondiale e, contestualmente, la guerra di Liberazione dal nazifascismo per il nostro Paese?
«La Seconda guerra mondiale fu il grande inverno dell’umanità, ma come il grano sotto la neve, la libertà riuscì a germogliare. Proprio dove i principi fondamentali del vivere umano venivano negletti e cancellati, ci fu qualcuno che, anche a costo della propria vita, riuscì a custodirli: il Manifesto di Ventotene del 1941 venne stilato al confino, ma a questo si possono aggiungere le esperienze da esuli e nei campi nazisti.
La guerra di liberazione fu per l’Italia un riscatto, un momento di orgoglio, che per tutto il ventennio era stato calpestato con le complicità della monarchia e anche di altri attori di primo piano della vita economica, industriale, militare e anche ecclesiastica italiana. La lotta di liberazione ebbe certamente anche le sue contraddizioni, ma nel caos scatenato dai totalitarismi non poteva essere altrimenti. Spesso sento forze politiche che rifiutano la memoria della Resistenza. Si giustificano dicendo che ci sono stati eccessi oppure che era politicizzata. Certamente in alcuni contesti gli eccessi ci sono stati, ci sono ormai molti testi che hanno ricostruito queste pagine buie. Tra i partigiani vi erano certamente esponenti di varie forze politiche, ma anche tanta gente comune. Ragazze e ragazzi. Molti di loro nemmeno avevano avuto la possibilità di formarsi politicamente, alcuni avevano anche creduto alla propaganda fascista, avevano conosciuta solo quella, il loro risveglio dal ventennio fu duro e amaro. Nelle fila partigiane vi erano socialisti, comunisti, azionisti, cattolici, ma anche soldati e monarchici, tanti altri senza bandiera politica. I numeri non erano straordinari nelle quantità (molte città furono liberate solo dai partigiani, penso a Genova), ma diedero riscatto e orgoglio anche a quella zona grigia che era stata a guardare. Il loro sacrificio riconsegnò l’Italia alla libertà e alla democrazia. Erano una parte della società italiana, ma hanno lottato per tutte e tutti».